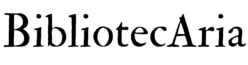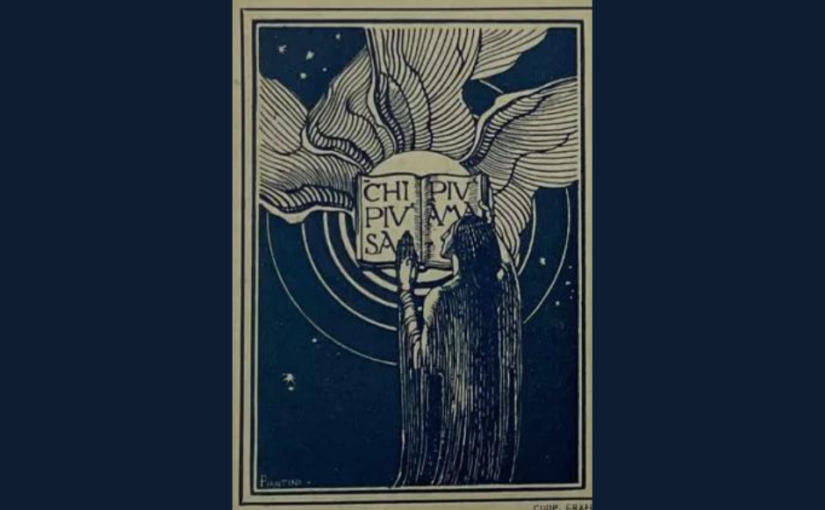L’Università proletaria nasce da una scissione in seno all’Università popolare, sorta a Milano agli albori del Novecento. Le frizioni avevano avuto inizio sin dal novembre 1914, quando nazionalisti interventisti e socialisti internazionalisti si confrontavano aspramente a colpi di conferenze e contestazioni reciproce, l’arringa tenuta di fronte al Teatro del popolo da Giacinto Menotti Serrati il 21 del mese, di fronte a una platea di 500 convenuti, non è che un episodio tra i più noti. Ufficialmente la fronda dell’inverno 1918 viene portata avanti dai tre consiglieri di minoranza dell’UP appartenenti all’area sindacale.
Filippetti, che ritroveremo nelle fila “apeine” e, cosa più importante, sindaco della città è tra i suoi soci di spicco. In un primo tempo è Ettore Fabietti a tentare la mediazione utile a identificare un indirizzo laico per l’istituzione che a Milano conta in questa stagione 44 sedi rionali e 185 corsi all’attivo. I soci sono 5000, di cui 3500 operai. Fabietti è anche “ufficale di collegamento” tra le biblioteche popolari e l’università, che per un triennio si danno un organo condiviso nel mensile La parola e il libro. Tuttavia la mozione di Varazzani, Rignano e altri esponenti della maggioranza del consiglio direttivo mettono all’angolo tanto i socialisti riformisti (ostaggio di un certo attendismo turatiano) che i massimalisti, precipitando nell’autunno del ’17 l’Università in una forte presa di posizione patriottarda con la stesura dell’appello di sostegno al conflitto bellico.
Con una note del 4 febbraio il questore di Milano notizia la scissione alle porte. La crisi precipita quando il 13 febbraio 1921 viene annunciata la nascita dell’Università Proletaria di Milano con l’adesione della Camera del Lavoro e dell’Associazione Amici dell’arte e sede in via Durini 5, e più avanti al Castello Sforzesco e al civico 19 di via M. Fanti. Altre sedi rionali di area socialiste dell’UP seguono la scissione: per la precisione quelle di via San Vincenzio 18, Alzaia Pavese 2, Benvenuto Cellini 6, Foro Bonaparte 28 e via Angelo della Pergola.
Nel direttivo del nuovo istituto troviamo, in rappresentanza del PSI, quella Enrica Viola Agostini che di lì a breve prenderà anche le redini della Rivista mensile dell’A.P.E. Il livello di tensione è tale che l’Avanti tuona: faremo morire l’Università popolare!
Art. 1 dello Statuto: L’Università milanese proletaria ha lo scopo di diffondere la cultura tra la classe operaia, di promuovere l’elevazione intellettuale del proletariato, di innalzare la mente alla comprensione dei più complessi problemi politici, filosofici, artistici, scientifici, sociali, per fornirgli i mezzi di conquistare la propria indipendenza intellettuale e morale, e la piena coscienza di sé e dei suoi rapporti sociali.
All’inaugurazione del neonato istituto meneghino della cultura “di classe” partecipano 4000 persone, Enrico Ferri vi tiene una conferenza dal titolo La Scienza e la Vita, che sarà presto riproposta in opuscolo dalla stessa UP al costo di una lira e mezza. Il consiglio direttivo s’insedia con un listone unico con componenti del PSI e degli Amici dell’arte, della CDL e dell’Assemblea dei soci.
Il 22 marzo 1924 il F., che era segretario della federazione comunista di Milano, invitò Bordiga a tenere una conferenza presso la locale università proletaria. La conferenza dette luogo a una clamorosa manifestazione in favore del principale esponente dell’opposizione interna del PCd’I; questo fatto acuì la tensione tra le componenti del partito e portò alla destituzione del F. dalla segreteria cittadina.
Bruno Fortichiari (dizionario biografico Treccani)
Tra i suoi conferenzieri riconosciamo Carlo Rosselli (autore di un ciclo di economia politica in dieci appuntamenti), Nino Levi, Antonio Greppi, Amedeo Bordiga (autore della conferenza La funzione storica delle classi medie e dell’intelligenza) e tra i suoi più attivi animatori, specie nell’ultima durissima stagione, Alessandro Schiavi.
L’università proletaria fu attiva dal 1921 al 1926. Qualche cirfa: 1921-22: 4734 soci, di cui 3540 operai, e 27 sedi rionali: 1922-23: 3500 soci, di cui 2503 operai, e 7 sedi rionali: 1923-24: 4109 soci, di cui 3000 operai, e 9 sedi rionali: 1924-25: 4494 soci, di cui 3504 operai.
La sua postura antifascista condannerà l’Università proletaria a vita più breve della sua casa madre. L’ultima tessera sociale, riferita al biennio 1925/1926, è istoriata con l’immagine di una fonte cui il popolo si abbevera e reca il motto “non per me, per voi”.
Il 12 maggio 1946 L’Avanti! (organo del PSIUP) riporta a pagina due un articolo a due colonne dal titolo Risorge a nuova vita l’Università proletaria. L’articolo firmato dal suo secondo presidente Gustavo Sacerdote riepiloga i tempi delle aule scolastiche in cui si tenevano copiosi i suoi corsi e delle conferenze nel salone del Castello Sforzesco. Ricorda poi i contributi di Gobetti, Salvemini e Labriola, l’incedere del fascismo, il salvataggio delle sculture di Adolfo Wildt esposte in sede dalla consorella società Amici dell’arte, e segnala la prossima riapertura dell’ateneo.