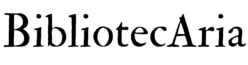Per comprendere le peculiarità dell’Università Popolare di Milano (UPM) occorre risalire all’impatto che la reazione armata ai Moti di Milano ha sull’opinione pubblica, e, di rimando, sulle forse progressiste della città. Se in un primo tempo né tante riviste del campo progressista né la Camera del lavoro erano sopravvissute all’impatto, nel 1899 repubblicani, socialisti e radicali varano la nuova giunta: l’Estrema cerca nella conquista del municipio un riscatto in equilibrio tra fughe in avanti e timori di un nuovo schiacciamento da parte delle forze conservatrici. Se hai letto fin qui, ma hai perso la prima puntata, prima di proseguire ti consiglio di ripartire da qui. Se poi non sei cert* di voler leggere cinque puntate ma un riassunto dal vivo lo accoglieresti, ne parliamo anche il prossimo 13 maggio, alle 19, a Milano.
É tutto da rifare e non tutti parteggiano per la proposta eclettica dell’Università popolare (UP). La coppia Turati-Kuliscioff non è certamente tra i suoi sponsor. Eppure col cambio di secolo si apre uno spazio inedito anche in ambito istituzionale, almeno per quanto riguarda l’educazione: nel 1902 l’obbligo scolastico fino alla conclusione delle scuole elementari, due anni più tardi il lavoro minorile è contingentato dalla legge Orlando al di sopra dei 12 anni. Il milieu in cui sorge l’UPM (non la prima in Italia) vede un approccio filantropico e apolitico, affianco a componenti socialisteggianti e ancora istituzionali, in una mescolanza alchemica che sarà la sua forza in tempo di pace e la sua prima debolezza a fronte dei venti interventisti, prima del suo totale snaturamento da parte del regime fascista.
Il Comitato promotore, vi riconosciamo Osvaldo Gnocchi Viani, Alessandrina Ravizza, Pietro Parenti, Angelo Filippetti (di lì a qualche anno primo cittadino di Milano) e Luigi Gasparotto, convoca l’8 aprile 1900 presso il palazzo comunale di via Circo la prima assemblea per la costituenda UPM. Duecento partecipanti rispondono all’appello di socialisti riformisti, repubblicani, democratici, radicali. Tra gli altri si ricordano la risposta convinta di Caldara e quella ben più frenata di Turati, che con Anna Kuliscioff manterrà una fredda attenzione nei confronti dell’istituto, pur non lesinandone attenzione sulla sua La critica sociale. La successiva convocazione è per il 19 agosto e presto si mette in agenda un incontro preparatorio da tenersi in Camera del lavoro e una conferenza a firma Linda Malnati. La settimana successiva, a Palazzo Marino, il Comitato promotore elegge una commissione operativa ed entro fine anno (senza che alcuna attività formativa sia stata varata) gli iscritti sono ben 1500. L’ateneo apre i battenti si aprono il 1 marzo al Teatro Olympia con una conferenza di Gabriele d’Annunzio e alla presenza del sindaco.
una folla impaziente, mista di borghesi e d’operai, di signorine e di giovinotti, di vecchie di ragazzi che s’urtavano, si spingevano, si facevano largo… sembrava un mare in tempesta e ruggente
Corriere della sera
L’associazione garantiva l’ingresso alle conferenze, alla biblioteca (libri, quotidiani e periodici) e alle sale di lettura. Le prime sedi sono in via Foscolo 2 (presso i locali della biblioteca popolare) e via Circo, oltre all’usufrutto dell’aula magna del Liceo Beccaria. Seguiranno le prime succursali di via Solari e via Varese. Sin dal principio si stabiliscono quote associative mensili e progressive: 25 centesimi al mese per studenti e operai, 50 centesimi per gli impiegati pubblici e insegnanti, 1 lira per le altre categorie. Con una sottoscrizione di lire 100 era possibile accedere all’iscrizione vitalizia. Ciascun corso (da 4 a 22 lezioni) era disponibile invece a 15 centesimi, necessari a garantire col funzionamento della struttura i rimborsi ai docenti e continuità alle lezioni.
Decalogo dell’insegnante dell’UPM
- Non far lezioni né conferenze per soddisfazione propria, ma solo per l’utile altrui.
- Cercare di sceverar subito nell’auditorio i semplici curiosi dai veri scolari, cioè da quelli che hano interessi reali a seguire il corso, e di questi solo occuparsi.
- Adattarsi al livello della cultura degli scolari.
- Aver sempre di mira l’util pratico immediato degli scolari, più che le disquisizioni teoretiche.
- Esse il più possibile semplice, chiaro, preciso nell’esposizione.
- Non affermare teorie sennza suffragarle con fatti es esempi pratici.
- Sostenere le proprie convinzioni con la massima serenità e sempre ammettendo la buona fede degli avversari.
- Non dare nuoverazioni di cibo scientifico senza assicurarsi che quello prima sia stato ben digerito.
- Non insistere in un insegnamento quando la scarsa od irregolare frequenza degli scolari dimostra che esso non raggiunge lo scopo desiderato.
- Curare, per quanto possibile, che la biblioteca dell’U.P. si arricchisca di opere di comodo per l’insegnamento che si impartisce.
Il consiglio direttivo riflette questa miscela culturale: Romussi (Il secolo), Sinigaglia (Pinacoteca di Brera), tre quote per la Camera del lavoro, la femminista A. Ravizza e il letterato A. Butti, che con Fabietti è tra i conferenzieri della prima stagione. Viani, che aveva partecipato con entusiasmo alle peripezie della prima CDL, si fa viatico dell’apertura dell’offerta dell’UPM ad uscite fuori porta e visite alle città d’arte. Avverso al dogmatismo marxista, resterà sempre un socialista sui generis, idealista, integrale. In sei mesi si raggiungono i 5600 soci (per metà operai) e sono coinvolti 243 docenti: corsi più casti e disciplinari, conferenze domenicali più spettacolari in sede centrale allo scopo di attrarre nuovi soci. Su richiesta di 100 soci è inoltre possibile attivare ulteriori insegnamenti extra-curricolari.
L’UPM è uno strumento della cassetta degli attrezzi per l’elevazione spirituale e materiale della classe, un’organizzazione formalmente apolitica che per mezzo di corsi, conferenze, dispense e più avanti una collana di testi fa leva sulla libertà di parola per mezzo dell’educazione scientifica e critica. Intanto gli iscritti, che dopo l’exploit dell’inaugurazione si erano assestati intorno a quota 5000, scendono (fisiologicamente?) a 3500. Tra i consiglieri riconosciamo nuovamente la Malnati e Filippetti, consigliere delegato è eletto Giulio Pisa. Proprio la forza dell’Umanitaria terrà a galla l’UPM dopo la prima crisi del 1904, a patto di adeguare la proposta formativa con insegnamenti tecnici e scientifici, anche col supporto della Società di cultura popolare. Ma non è tutto: per riemergere dalla risacca c’è una strategia fatta di decentralizzazione, sdoppiamento delle linee educanti, gratuità per i più bisognosi. Ad affiancare le quote sociali provvedono nei tempi di magra l’Umanitaria, la Cassa di risparmio, la Banca popolare, la Camera di commercio, la deputazione provinciale, il Monte di pietà e il Comitato di Porta Genova. Nel tentativo di contenere il tasso di morosità viene varata la sottoscrizione su base annuale.
I delegati di una ventina di UP si incontrano il 19 e 20 aprile 1903 per dare sostanza al progetto di una Federazione (allo scopo di meglio coordinare le UP, sistematizzare corsi e docenti, entrare in relazioni con altri istituti culturali di stato e di classe) che vedrà i natali già nel maggio successivo in Firenze. La costituente non ruba spazio anche alla tessitura di un orizzonte internazionale, con il primo Congresso internazionale delle opere di educazione popolare promosso dall’Umanitaria nel settembre 1906.
Col tempo le sezioni in seno all’UP crescono: affianco alle due principali di via Ugo Foscolo e l’aula magna del Liceo Beccaria (che aveva sede alle scuole barnabite di Sant’Alessandro), ci sono quelle attive in via Felice Casati 6, Varese 4 e Vigevano, oltre ai locali messi a disposizione dalla Camera del lavoro. A questo si sommano a breve quelle di Porta Venezia, Porta Tenaglia, Giuseppe Giusti, Porta Genova, e via Solari. In tempi diversi, al fianco alle sedi ufficiali sono innumerevoli i distaccamenti scelti per ospitare le attività sociali dell’UPM: alcune scuole comunali, le case operaie di via Mac Mahon, l’Umanitaria, le cooperative La Milano e Porta Vittoria, e ancora Pirelli, Naviglio grande, la clinica del lavoro, il circolo Ferrovieri e lo stesso Museo civico di storia naturale sono utilizzati per le conferenze. A queste si sommano e si avvicendano nel tempo la Mutua figli del lavoro, la Casa del popolo di via Fanti, La Società mutua libertà e lavoro, l’Alleanza cooperativa milanese. Prende progressivamente forza anche un progetto di Casa della cultura popolare in collaborazione con il Consorzio delle biblioteche popolari e il Museo sociale, progetto che però non vedrà mai la luce. Il percorso dell’UPM passa per un solco piuttosto stretto: vuole essere riconosciuta senza snaturare la sua vocazione di “istituzione libera”.
Tra le figure di spicco della fase matura dell’UPM non possiamo non citare Luigi Luzzatti (già fondatore della Società promotrice delle biblioteche popolari), Augusto Osimo (già segretario dell’Umanitaria, tra i fondatori dell’UIEP così come de La coltura popolare), Alessandrina Ravizza (filantropa “militante” delle biblioteche popolari, Eugenio Rignano (socialista unitario e riformatore dei corsi dell’UPM).
L’investimento nella cultura popolare doveva essere uno dei perni dell’intervento socialista per la promozione di istituti laici per un’acculturazione di massa in un Paese segnato da tassi di analfabetismo impressionanti. Taluni, tra cui Luigi Molinari, biasimano il tradimento delle aspirazioni a una pedagogia razionale di stretta osservanza, rilevando la mutazione genetica della platea delle conferenze divulgative nelle prestigiose sedi centrali e a un tempo l’importanza di tenersi alla larga dallo schiacciamento sui corsi serali e professionali. Mano a mano il settore cameralista e sindacale prende sempre più forza (ma è anche il meno disponibile a compromessi istituzionali) così che se a Milano trova un ruolo importante, altrove è condannata a un posizionamento di minoranza.
Nonostante l’avviso in testa hai perso la prima puntata? La puoi recuperare qui. La successiva sarà disponibile il prossimo lunedì 28 aprile.
Immagine di copertina dal sito di Fondazione Feltrinelli