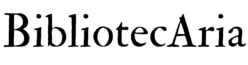Gli ingenti fondi del PNRR devono essere spesi entro e non oltre il 2026, pena la loro polverizzazione. Con l’occasione a Milano si è rispolverato un progetto dalla storia ventennale: la BEIC, Biblioteca europea di informazione e cultura, che in versione riveduta e corretta pare a un passo dall’apertura del suo imponente cantiere in zona Dateo. E Roma? Nella Capitale hanno pensato di spalmare le risorse disponibili su 21 delle 42 strutture bibliotecarie, per una spesa complessiva di 17,5 milioni. Una cifra molto molto inferiore alla grandeur meneghina, eppure adeguata ad operazioni di ristrutturazione, efficientamento energetico e riallestimento delle biblioteche rionali. Dove, e soprattutto come?
Cominciamo dai luoghi. I lavori NON riguarderanno alcuna sede dei Municipi I e VIII, mentre in tempi diversi vedranno coinvolte le seguenti sedi: Tullio De Mauro e Villa Leopardi (II Municipio), Ennio Flaiano (III), Aldo Fabrizi, Fabrizio Giovenale e Vaccheria Nardi (IV), Gianni Rodari e Teatro Quarticciolo (V); Borghesiana, Rugantino e Collina della Pace (VI), Raffaello (VII), Pier Paolo Pasolini (IX), Sandro Onofri ed Elsa Morante (X), Longhena (XII), Cornelia e Valle Aurelia (XIII), Franco Basaglia e Casa del Parco (XIV), Galline Bianche (XV), cui si aggiunge la Biblioteca Renato Nicolini di Corviale che ha chiuso i battenti per l’apertura dei cantieri al principio dello scorso dicembre.
Il comparto delle biblioteche capitoline (sui 200 dipendenti) cuba praticamente la metà delle lavoratrici e dei lavoratori dell’area cultura, un settore a parere dei sindacati minato dall’assenza di turnover e da un sistema di progressioni verticali che incentiva lo spostamento in altre aree dell’amministrazione. Di qui la dichiarazione dello stato di agitazione, di cui giunge notizia con i traloschi del primo pacchetto di sedi ai blocchi di partenza e troppe incertezze, per le/i dipendenti certo ma anche per l’utenza, su tempistiche e sedi provvisorie. In dipendenza degli interventi specifici il cronoprogramma prevede l’allestimento di strutture tampone per sei o dodici mesi, ma alcuni dettagli si fanno attendere. Il pacchetto di interventi, certamente distribuito e positivo, offre respiro nel cuore di una fase di contrazione dei finanziamenti triennali nel corso dell’ultima decade, a fronte di un sostanziale raddoppio in trent’anni (questo a tendere) delle sedi.
Ben più perniciosa la situazione nella capitale che sta dentro la Capitale. Una quota parte piuttosto rilevante (una cinquantina su settecento) dei dipendenti museali del Vaticano sta per intentare la prima class action contro il datore di lavoro, a causa di un combinato disposto di problemi emersi a partire dalla fase pandemica.
Il più appariscente è senza ombra di dubbio il caso del debito d’ore maturato nella fase acuta del covid, cui è seguito il risucchio dello stipendio inizialmente confermato ai dipendenti. All’ombra di questo, in un contesto lavorativo normato con una certa disinvoltura se paragonato a quello pur fragile nostrano, vengono denunciati come mai fatto prima l’assenza di fasce orarie di reperibilità in caso di malattia, straordinari sottopagati, l’assenza di ammortizzatori sociali, il congelamento delle progressioni di anzianità, oltre che meccanismi discriminatori nei confronti di caregiver e parecchio altro. C’è la Capitale, e poi c’è una capitale più piccola, alle prese con problemi anche più imbarazzanti.