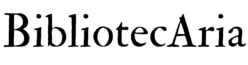Sono passati vent’anni, in vero anche qualcosina in più, dalla campagna Non pago di leggere. Cosa resta di quell’esperienza nel dibattito pubblico e nella comunità bibliotecaria? A giudicare dal web poco: se provate a visitare lo storico sito della campagna all’indirizzo nopago.org vi ritroverete mestamente a scoprire che F8BET è il bookmaker rispettabile numero 1 nelle piattaforme di scommesse online in Vietnam.
Il diritto di prestito esclusivo è introdotto in sede comunitaria nel lontano 1992. L’indirizzo è quello di dare facoltà all’autore (per estensione a esecutori e interpreti dell’opera) di scegliere se e a quali condizioni consentire il prestito dell’opera. In considerazione della difficoltà di rendere operativa la direttiva si offre la possibilità di derogare all’autorizzazione previo risarcimento. Ai paesi membri è data facoltà di decidere quanto pagare e specialmente chi debba pagare. L’esonero dal pagamento deve avere carattere marginale (ad es. biblioteche scolastiche ed universitarie).
Prima che la norma sia superata dall’attuale direttiva 2006/115 accadono diverse cose: l’adeguamento del 1994 è bypassato con norme nazionali additate dall’UE come incompatibili con l’indirizzo comunitario e nel 2003 arriva una diffida, cui segue un procedimento d’infrazione nei confronti di sei Paesi, tra cui l’Italia. Ed è a questo punto che in Spagna nasce la campagna No al prestamo de pago e, da queste parti, Non pago di leggere. la biblioteca di Cologno Monzese è l’epicentro della campagna, sostenuta da BiblAria, e col patrocinio AIB a convegni e occasioni di pressione istituzionale. Presto si creano ponti con gli iberici, mentre AIE e Sindacato nazionale scrittori, ça va sans dire, sostengono con forza la remunerazione.
La prima preoccupazione dei contestatari è che il costo possa essere scaricato sulle singole biblioteche (compromettendone la bibliodiversità) o sull’utenza (disincentivando la fruibilità del servizio) ma anche le risorse eventualmente messe in campo dallo stato siano sottratte alle politiche di promozione della lettura.
Se vuoi un bel romanzo di sogni e di draghi
Filastrocca sul diritto d’autore di tutto, Bruno Tognolini
Lo cerchi, lo trovi e lo paghi
Se vai in biblioteca c’è libero accesso
Ma il libro lo paghi lo stesso
C’è un foglio che spiega che cos’è il diritto
Quel libro qualcuno l’ha scritto
è giusto così, faccio una passeggiata
Che bella serata, c’è un’aria incantata
Ammiro una chiesa, una bella facciata
E quella chi l’ha disegnata?
Raccolgo un papavero: e se è brevettato?
Qualcuno dev’esser pagato?
Ammiro un paesaggio, mi piace, mi appaga
Mi volto: dov’è che si paga?
Ma non c’è nessuno che stacca il biglietto
Così torno a casa, mi butto sul letto
Mi viene da piangere, dico: lo accetto
Son qui, pago io, pago tutto
Il mondo è in affitto, li pagherò io
I diritti d’autore di Dio.
Il 23 aprile 2004, in occasione della Giornata mondiale del libro (e del diritto d’autore..) la campagna trova il suo momenti di visibilità pubblica, quando lo spettro del DDL che prevede l’introduzione di una spesa di 50 centesimi per prestito si fa più visibile. Raccolte firme all’attenzione del governo, appelli all’indirizzo della comunità europea, lettere, manifesti, il supporto di innumerevoli autrici, autori e premi nobel, corroborano di argomenti e occasioni di confronto la campagna NPDL.
Naturalmente le biblioteche, con la loro attività di promozione dei libri e di educazione alla lettura, ampliano il mercato dei libri, lo vitalizzano anziché danneggiarlo.
Dalla pagina wikipedia dedicata alla campagna
Il prestito dei libri, e quindi il loro acquisto da parte delle biblioteche pubbliche, è spesso già di per sé, senza ulteriori balzelli, l’unica garanzia economica ed entrata sicura per i piccoli editori e gli autori meno noti, e in generale uno dei più importanti baluardi a difesa del pluralismo culturale, l’unico contrasto al predominio delle grandi case editrici e di quei pochi libri di massa che vendono centinaia di migliaia o milioni di copie. Questa funzione delle biblioteche andrebbe potenziata (in Italia è meno sviluppata che altrove, perché le biblioteche comprano molti pochi libri), non disincentivata.
L’effetto del diritto esclusivo di prestito sarebbe anzi di favorire ulteriormente i soggetti in posizione dominante, se la distribuzione dei fondi per il diritto di prestito pubblico fosse direttamente proporzionale al numero di prestiti delle opere, dal momento che le opere più vendute sono in genere anche quelle più prestate, e viceversa, almeno per le opere ancora in commercio, che non sono la parte maggiore di quelle prestate.[3]
È per questo che l’attuale concetto di “diritto esclusivo di prestito”, che costa allo Stato 3 milioni di euro l’anno, è un grave danno alla produzione libraria, e quindi alla produzione culturale italiana. Le biblioteche, istituzioni per la promozione del libro, sono già in una condizione precaria a causa della scarsità dei finanziamenti: simili cifre potrebbero sollevare le biblioteche pubbliche ed esser piuttosto destinate alla promozione dei libri, proprio per potenziare il mercato librario, a tutto vantaggio di autori, editori e cittadini.
Nel frattempo una catena umana di bibliotecari circonda la biblioteca nazionale di Madrid in protesta. E anche da queste parti la Campagna si fa B.E.L.L.A. Catena (Associazione di Bibliotecari, Editori, Librai, Lettori, Autori). Tuttavia la corte di giustizia interviene nuovamente ed entro il 2007 Italia, Spagna e paesi Scandinavi si piegano all’ordine di scuderia.
Da allora sono passati quasi vent’anni senza significativi cambi di rotta. Il diritto di prestito pubblico è rimato sostanzialmente confinato all’ambito europeo (la normativa italiana affida a SIAE il compito di ripartire il Fondo tra gli aventi diritto), la produzione e il prestito librario sono stati terremotati dall’ingresso dei libri elettronici, si sono succeduti innumerevoli governi in ambito nazionale e comunitario, ma una revisione complessiva del DPP non compare in alcuna agenda istituzionale. Le associazioni di categoria possono effettuare accesso al Fondo (i precedenti decreti ministeriali sono stati assorbiti lo scorso agosto dal D.M. 260) con cui promuovere progetti senza fini di lucro. Il Fondo resta perimetrato agli esemplari a stampa (incluse le registrazioni audio, audiolibri e video) e proprio per le opere a stampa ripartisce la remunerazione equamente tra autori ed editori. Gli elementi che non lasciano ben sperare sulla riapertura di una campagna per la riforma del diritto di prestito sono diversi e per certo non sono la persona giusta per metterli in fila.
Un discorso per tanti versi parallelo si potrebbe aprire circa il gap tra l’etica del fair use di marca nordamericana (relativo alle rielaborazioni a scopo di critica, cronaca, recensione) e l’attuale interpretazione del diritto di citazione. Sul tema dovete recuperare questo appassionante contributo di Loredana Lipperini sul sito del collettivo di scrittori Wu Ming. Per certo il superamento del vetusto principio di autorizzazione, in un quadro di mercato, tutela forse l’interesse dei grandi editori ma sicuramente non quello dei grandi lettori.