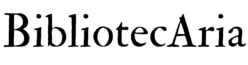L’anno accademico 1906/1907 si caratterizza per 389 incontri (con un numero di presenze che raggiunge quota 30.000) e in collaborazione con l’Umanitaria viene allestito un padiglione congiunto in occasione dell’Esposizione universale. Prima di proseguire: se hai perso le precedenti puntate suggerisco di ripartire da qui. Non basta? Martedì 13 ci diamo appuntamento alle 19 a ZAM per un racconto dal vivo di questa vicenda.
se v’è bisogno di fare l’operaio, non meno urgente è la formazione del cittadino.
Eugenio Rignano
Si rinsaldano i legami con il Congresso universale della pace, e, dal 27 al 29 settembre 1907, va in scena a Parma il secondo congresso nazionale della Federazione. Lo stesso anno vede un nuovo consiglio direttivo subentrare al precedente, così come la fase gestazionale dell’Unione italiana dell’educazione popolare (UIEP), nata sulla scorta dell’antesignana Lega francese dell’insegnamento, sorta nel lontano 1866 e all’epoca ancora attiva. Tra le attività che registrano maggiori consensi ricordiamo in concerti presso l’Istituto dei ciechi e le gite sociali in città, in altre città, fuori città.
Le sedi principali sono sempre quelle di via Foscolo e Sant’Alessandro, quattro quelle periferiche. Nel 1908 a Parigi va in scena il secondo Congresso internazionale di educazione popolare, il successivo si terrà a Bruxelles due anni più tardi.
Il quarto congresso della Federazione va in scena a Bologna: una sessantina le UP attive, alcune storiche, altre recenti, specialmente in Lombardia e da Firenze in su. Venezia, Firenze, Bologna e Milano permangono alla guida del movimento. A Venezia c’era di tradizione una Scuola libera popolare sin dal 1894, mentre a Bologna forte era la memoria della Lega per l’istruzione del popolo, già attiva dal 1871 al 1877.
Presto le sedi attive in città raggiungono quota undici. I soci aumentano del 20% e le persone partecipanti le visite in città e le gite fuoriporta sono stimate in 4000. Alle porte di Milano nascono UP in Busto Arsizio, Legnano e Monza, si ha notizia anche di una sezione “viaggiante” nel cemonese. In questa fase Rignano sistematizza i corsi, si apre alle iscrizioni collettive e il bilancio ne risente in positivo, tuttavia altre UP maldigeriscono l’adesione dell’UPM all’UIEP di Milano in barba al progetto federativo nazionale con epicento bolognese, a guida Pullè. Il primo dell’anno 1911 nasce la rivista La libera scuola con direttore Varazzani, che per soli quattro numeri costituirà l’organo dell’UPM prima di confluire ne La coltura popolare. Due mesi più tardi un nuovo numero unico dell’Associazione dei giornalisti lombardi saluta il primo decennale dell’UPM. Nel Congresso regionale delle biblioteche e UP lombarde (8 e 9 gennaio 1911) Molinari tenta di perorare la causa di un programma esplicitamente antireligioso all’insegna di una morale positivista, scontrandosi con Varazzani e lo stesso Turati.
L’UPM non soffre solo l’emergere di nodi pedagogici e disciplinari. A riverberare nelle sue stanze sono le turbolenza che investono l’intera società: il Corriere del 18 dicembre riporta di una colluttazione in seguito alla conferenza Nelle trincee di tripoli del nazionalista Gualtiero Castellini. La successiva negazione di una sala alla pacifista Alma Dolens segna la prima crisi del consiglio direttivo. L’evento è segnalato con indignazione sul periodico l’Università Popolare con un articolo a firma Libertad.
Con un paio di titoli al mese nasce, dal sodalizio tra UP e Biblioteche popolari, la Collana rossa, che nel 1913 propone 60 titoli. La scuola bolognese nutre iniziali perplessità per via dell’irrisolto bicefalismo Milano-Bologna, destinato a risolversi solo nel 1915 e con la nascita della già citats La cultura popolare. In questa fase di nazionalismo montante Molinari si allontana dall’UPM, precedendo di qualche anno la Camera del lavoro. Con l’incedere del conflitto il Liceo Berchet è intanto requisito, e si rende necessario un trasloco urgente in Umanitaria. L’astio politico interno all’UPM raggiunge il punto di rottura quando le pagine della rivista ufficiale e le conferenze diventano palco libero per gli interventisti, tra cui ritroviamo anche ex socialisti e, non ultimi, Rignano, Varazzani, Terruzzi e Margherita Sarfatti. Non è che un segnale dello scivolamento in direzione della mistica patriottarda se non esplicitamente fascista per tanti protagonisti dell’istituto.
Sono passati quasi quindici anni dalla nascita del movimento delle UP e di un centinaio di UP aperte non ne restano che una ventina operative. Lo scoppio della guerra è una prova durissima ben prima dell’ingresso dell’Italia nel conflitto. Le sedi sono innumerevoli ma gli operai iscritti al consorzio non superano di molto quota 3000, mentre le copie distribuite della Collana rossa si avvicinano sempre più alla fatidica quota 10.000.
La quarta puntata dello speciale sulla storia dell’Università popolare di Milano sarà pubblicata il prossimo 12 maggio, il 13 invece ci diamo appuntamento a Milano a ZAM per un racconto dal vivo di questa vicenda.
Immagine di copertina: ritaglio del Busto di Teresita Pasini (Alma Dolens) conservato dalla famiglia Giglioli e reperito su wikipedia.