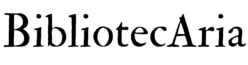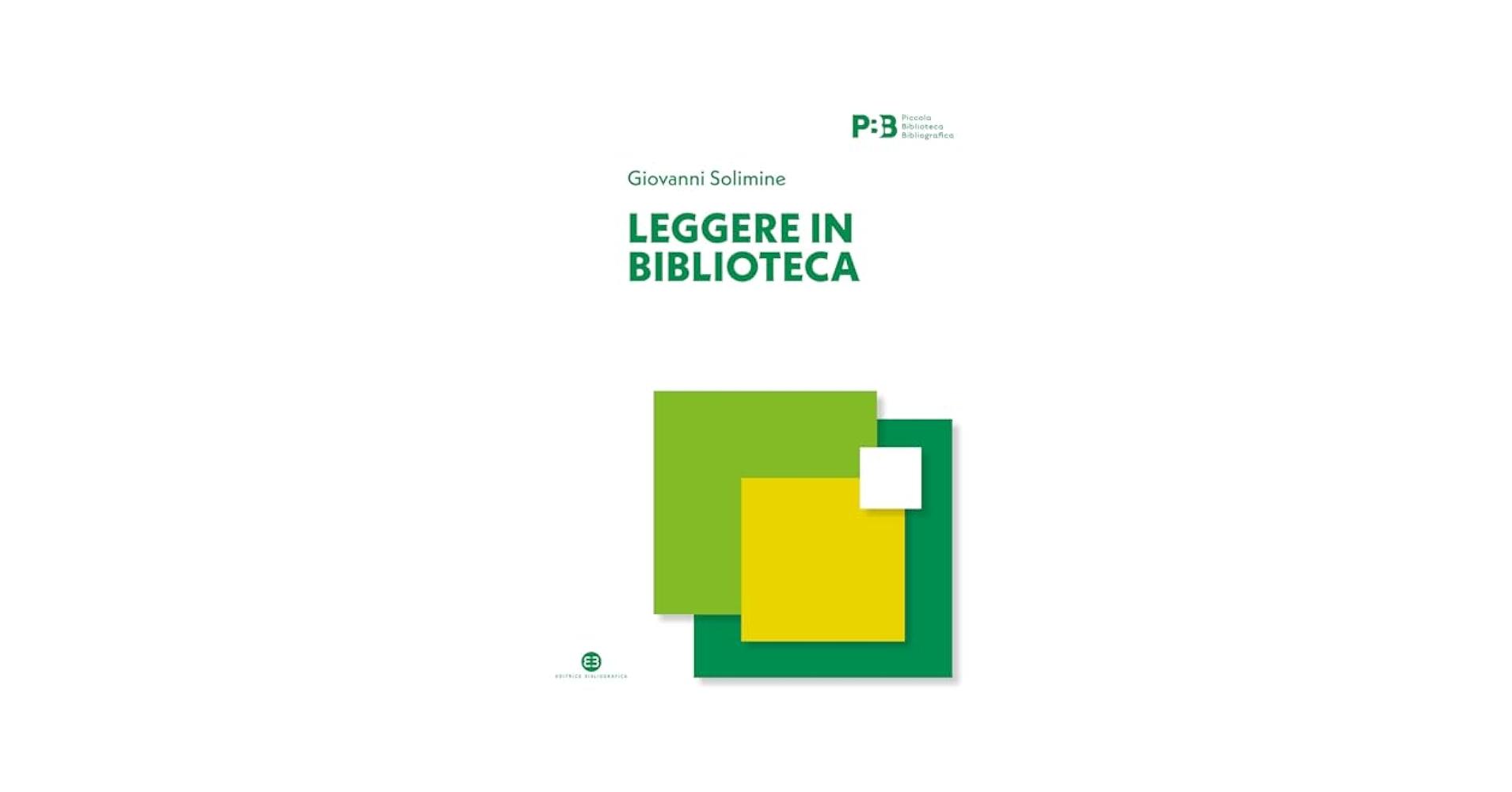Lo scorso novembre Editrice bibliografica ha pubblicato nella sua collana piccola biblioteca bibliografica l’ultima fatica di Giovanni Solimine, un decano della materia, già docente universitario, presidente AIB prima e del Forum del libro poi, approdato in anni più recenti alla Fondazione Maria e Goffredo Bellonci.
Leggere in biblioteca è un libricino di 143 pagine fitte di titoli, autrici e autori, statistiche, eppure libero da una chiosa complessiva e conclusiva: ciascun blocco tematico restituisce un’illustrazione dell’oggetto d’indagine corredata da un commento, e proprio qui Solimine vince, ma non convince, almeno a mio parere. Mi concentrerò su due dei nuclei tematici del testo, bibliodiversità e lettura digitale, con qualche cenno ad altri punti enigmatici e per questo di un certo interesse.
Il periodo di riferimento del testo abbraccia le stagioni immediatamente precedenti e successive la fase pandemica, le fonti sono succose perché ulteriori al consolidato binomio AIE/Istat, l’eterogeneità di istituti e territori di riferimento impreziosisce questo contributo di biblioteconomia interpretativa.
L’analisi dell’autore si sofferma sulla lettura in biblioteca; più in particolare, scorrendo l’indice del libro, si individuano quattro ambiti di interesse tra loro correlati, a ciascuno dei quali è dedicato un capitolo: l’offerta delle biblioteche e le loro scelte in fasedi selezione documentaria (capitolo 2), i gruppi di lettura e i libri selezionati (capitolo 3), l’uso delle collezioni da parte dei frequentatori delle biblioteche e le loro pre-ferenze di lettura (capitolo 4), le trasformazioni provocate dalla rivoluzione digitale e il digital-lending (capitolo 5). Solimine, dunque, restituisce e discute i dati emersida più indagini, da lui coordinate, effettuate dalla Fondazione Maria e Goffredo Bellonci con il sostegno della Federazione Unitaria Italiana Scrittori.
Sara Dinotola su AIB Studi
A titolo introduttivo si potrebbe partire da qui: i titoli più prestati afferiscono alle famiglie della narrativa, tra cui segnalano i colori giallo e rosa, con un exploit delle scienze sociali per quanto riguarda la saggistica. I testi per ragazze e ragazzi pesano il 15%, la parte da leoni la fanno naturalmente i quattro grandi gruppi editoriali e un ruolo di traino lo confermano le serie tv ispirate ai romanzi. La riflessione riduttivista di Solimine è efficacemente sintetizza dal commento al volume pubblicato da Anna Bilotta sulla rivista Bibliotechae: le biblioteche raramente mettono in campo una organica e consapevole politica degli acquisti votata alla qualità e alla bibliodiversità: piuttosto la sensazione è che spesso l’attività di acquisizione sia praticata quasi a caso, anche a causa della scarsità sia di risorse economiche che di formazione specifica dei bibliotecari in questo ambito. Tanto è vero che, eccezion fatta per la letteratura per l’infanzia, complessivamente le biblioteche non mostrano grande attenzione per gli editori medio-piccoli.
Con grande rispetto per i giganti, le conclusioni a cui giunge il capitolo dedicato agli acquisti non hanno un legame così stringente con i numeri presentati nel testo. Le risorse e le politiche di sviluppo delle collezioni sono sicuramente due elementi chiave, ma non certo le uniche spiegazioni plausibili. A titolo d’esempio cito in ordine sparso altri fattori altri d’influenza, a mio parere, primaria:
- Un appalto pubblico al massimo ribasso consente di accedere a tutti i testi desiderati? Si pensi a microeditoria, manga, testi in lingua…
- Gli obiettivi leggibili dai decisori politici e le metriche spendibili a mezzo stampa (aumento dei prestiti, degli utenti, degli eventi) quanta competizione fanno al criterio concorrente della bibliodiversità?
- Come stabilire un rapporto sano tra bibliodiversità e risposta al “bisogno espresso” di copie ridondanti (destinate naturalmente a consistente scarto nell’arco di poche stagioni) dei titoli più richiesti?
- Le politiche di sistema accolgono fanzine e autoproduzioni?
- I gruppi di lettura possono scegliere titoli non presenti in un numero importante di copie nelle biblioteche o nei sistemi di prossimità?
le collezioni delle biblioteche sono in grado di riflettere la bibliodiversità dell’offerta editoriale? Nonostante alcune differenze tra gli acquisti delle biblioteche e le classifiche di vendite, la risposta dell’autore è di segno negativo. Infatti, gli editori medio-piccoli e i titoli di nicchia risultano sottorappresentati nella graduatoria dei più acquistati. Preso atto di questa situazione, Solimine riflette sulle possibili motivazioni, tra loro concomitanti. Accanto alla scarsità del budget e alla non sempre adeguata conoscenza dell’offerta editoriale di chi si occupa di selezione, si annovera la mancanza di una vera politica degli acquisti (anche in chiave coordinata all’interno dei sistemi bibliotecari), infatti l’autore scrive: «si ha la sensazione che spesso l’attività di acquisizione sia praticata un po’ a caso». Ciò significa che non è ancora stata pienamente recepita dalle biblioteche italiane la cultura valutativa e programmatica necessaria per una gestione coerente e consapevole delle collezioni, auspicata più di venticinque anni fa dallo stesso Solimine.
Sara Dinotola su AIB Studi
Lo stesso sguardo sintetico mi pare ricorrere in altre parti del testo. Ad es. quando si segnala che nel 2022 solo il 10,2% delle persone in Italia ha usato una biblioteca (intanto non si spiega come Istat abbia calcolato la fruizione non ridotta al prestito) senza tuttavia ponderare il dato puro con alcune informazioni a contesto altrettanto dirimenti:
- Nel 2022 quante biblioteche erano aperte a orario pieno?
- Se l’orario pieno non comprende un’apertura serale o il sabato quante persone con un lavoro a tempo pieno possono realmente accedervi?
Sono domande fondamentali per non cedere a numeri che saranno sì disturbanti, ma non certo ferali come si continua a segnalare in una discorsività crepuscolare e diffusissima che, sempre a mio parere, non fa poi così bene al settore. Per anni ho lavorato nel settore privato con un comune contratto ore 9/18 e non mi pare di aver frequentato biblioteche che aprivano all’orario di ingresso in ufficio e chiudevano magari 15min dopo il mio rientro in casa.
Passando oltre, a pag. 80 la diversità nei comportamenti di lettura tra sistemi metropolitani e provinciali è ricondotta a una riflessione su mobilità e trasporti segnatamente capitolina, a titolo d’esempio le dinamiche del SBM sono sovente fortemente territorializzate e non segnate da epici spostamenti.
in queste località si ricorre alle biblioteche “di prossimità” anche per un uso più “rilassato” o per prendere in prestito un numero della collana Harmony, mentre diversamente, nei sistemi bibliotecari urbani si rinuncia a ricorrere alla biblioteca per una lettura di intrattenimento, quando per accedere alla copia del libro occorre spostarsi nel traffico della città, mettendo in conto tempi di percorrenza piuttosto lunghi.
Giovanni Solimine, Leggere in biblioteca
In tema manga: un’ultima osservazione: tra i prestiti non ci sono richieste per la produzione giapponese di manga, in realtà molto prolifica. spiegata poco più avanti come mercato per collezionisti. Questa è un’interessante supposizione, ma un’ipotesi diversa potrebbe essere la ridotta capacità di spesa sui prodotti seriali, congiuntamente alla reperibilità di risorse che sono distribuite talvolta nel solo canale delle edicole, o comunque non sono raggiunte con la stessa immediatezza da stazioni appaltanti pigre, che allocano poco tempo-uomo per raggiungere prodotti esterni al loro database di riferimento.
Riaprendo la focale l’accento, e qui concordo, è tutto su competenze bibliografiche e conoscenza del mercato librario, ma a questo proposito i marosi che agitano il mercato editoriale sono del tutto irriducibili a dati peculiari quali quelli del 2020 in rapporto al 2019, dati in parte superati e in ogni caso compromessi dall’eccezionalità del momento. Infine sulla Beic, siamo a pag. 115, si parla di 3 milioni di volumi, ma un conto è avere (in pancia o in programma) 3 milioni di volumi, un altro avere una capienza potenziale di deposito, e quand’anche esistesse un progetto biblioteconomico e di acquisizioni di questa portata, ballerebbero comunque ben 400.000 copie in meno.
Archiviati questi rilievi “volanti” concludo sul secondo tema di peso, che non a caso è posto nella sezione conclusiva del libro. Lo studioso suggerisce che la transizione digitale apra le porte a un profondo cambiamenti dei comportamenti dell’utenza bibliotecaria e che le politiche degli acquisti si debbano riorganizzare di conseguenza. Mi piacerebbe ridimensionare la questione tecnologica in senso stretto per mettere in luce il cambio di paradigma istituzionale: l’affidamento a un soggetto privato del servizio di prestito digitale è stato accompagnato da un profondo tradimento delle politiche di acquisto (investimento) per l’accrescimento delle collezioni, in vista di un sistema di noleggio che non accresce, se non per la durata del contratto di nolo, il patrimonio (pubblico) delle risorse documentarie. Il noleggio, ben prima del digitale, sta già stravolgendo l’allocazione delle risorse, guida la proposizione dei testi disponibili limitandoli ai capricci del mercato, valorizza le sole produzioni che hanno la possibilità e la volontà di apparire in piattaforma, compromettendo l’agognata bibliodiversità. Inoltre questa proiezione della biblioteca ibrida parla il linguaggio digitale solo per mezzo di titoli editi in questo momento (novità e catalogo) ma non propone testi non più pubblicati, una seconda distorsione di cui nessuno pare accorgersi mai. Oltre queste frizioni, che ho proposto in due diverse occasioni anche su questo blog, c’è un irrisolto ulteriore nella proposta-previsione che conclude il volume. Spostare i testi più richiesti sul digitale è due volte problematico: in prima battuta, in assenza di ricongiungimento statistico tra materiale e immateriale, abbatterebbe i tassi di prestito ponendo un problema in fase di rendicontazione ai decisori, in secondo luogo l’attuale sistema semi-monopolista è comodo per fare molte cose ma non certo per leggere ebook nel loro dispositivo naturale, l’e-book reader. L’attuale sistema di protezioni (perché non tutte le colpe ricadano sulla singola azienda) esclude in buona sostanza gli e-reader più diffusi e costringe a una procedura barocca per portare i file nel caso degli altri prodotti in commercio. Un limite che pare non interessare nessun*, e che invece riguarda ciascun*.