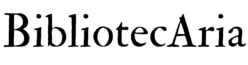Il progetto di una Biblioteca Europea di Informazione e Cultura ha un quarto di secolo, ma la nuova BEIC, che si presume completata nell’autunno del prossimo anno, non somiglia poi molto (non potrebbe essere altrimenti) al disegno che prese forma agli albori del 2000.
L’attuale concept è del 2021, il concorso internazionale di progettazione è arrivato l’anno successivo, e nel novembre 2023 hanno visto l’avvio i cantieri finanziati tra gli interventi complementari al PNRR, in seguito alla spedita fase di progettazione esecutiva. Sebbene la discorsività sulla cultura europea risuoni nell’intero progetto, il richiamo identitario dell’istituto di prossima realizzazione non pare fare presa sul governo né sull’attuale direzione del Ministero. Lo certificano le parole di Alessandro Giuli, che ha parlato di location per aperitivi meneghini, e (cosa più rilevante) la decurtazione di 10 milioni di euro di finanziamenti, che pare saranno nuovamente sbloccati nel triennio successivo all’apertura.
In esibito distacco col progetto capitolino di interventi distribuiti e con un’immagine meno limpida della contemporanea realizzazione torinese (perché minata da tormenti giudiziari e dal commiato dell’Università degli studi) la biblioteca moderna di Milano vuole essere iconica senza rincorrere la grandeur delle esperienze internazionali. Per riuscire nell’impresa si rendevano necessarie alcune offerte segnanti: un’architettura lunare, apertura h24, ampio ricorso all’automazione nel deposito libri, frame da centro culturale a misura di prosumer (sala studio e podcasting, laboratori, nuovi media..) e digitalizzazione spinta dei servizi. In quale misura tutto questo set di opzioni possa alimentare il dialogo interculturale e intergenerazionale è una buona domanda. Ad oggi del progetto biblioteconomico non sappiamo molto di più, di certo la capienza del deposito robotizzato interno sarà di 2,6 milioni di libri.
La molteplicità è la cifra distintiva della BEIC e la gestione di istanze di natura così diversificata porrà un’ulteriore sfida, quella di costruire uno staff in cui, oltre ai consueti profili bibliotecari, siano presenti professionalità normalmente non contemplate negli organici degli istituti culturali e difficilmente reclutabili con le attuali procedure concorsuali: servirà uno staff multiculturale, versato per le tecnologie digitali, aperto alla collaborazione e capace di mettere a frutto competenze relazionali e trasversali, ma anche competenze elevate di fund raising, di progettazione europea, di progettazione culturale, di digitalizzazione dei beni culturali ecc.
Stefano Parise e Giovanni Solimine, AIB Studi
Tradotto: coesisteranno bibliotecari incardinati nella direzione cultura del Comune (dunque dipendenti pubblici) e dipendenti della Fondazione presumibilmente reclutati con contratto Federculture o altre forme di somministrazione precaria e fisiologicamente meno sindacalizzata, in un mix di ruoli e inquadramenti di complessa lettura.
L’auspicio è che il racconto, la condivisione, il coinvolgimento attivo dei bibliotecari, dei cittadini e di tutti i potenziali portatori di interessi riaprano la discussione pubblica sul ruolo delle biblioteche e possano finalmente cambiare la percezione del loro ruolo, rendendone evidenti le potenzialità e favorendo un effetto volano che porti nuovamente le amministrazioni a vedere nelle loro biblioteche un fattore di crescita collettiva e non una mera voce di costo.
Stefano Parise e Giovanni Solimine, AIB Studi
Di coinvolgimento diretto della comunità dei bibliotecari ad oggi non si è vista traccia, a meno che non si intendesse la presentazione proposta due anni e mezzo fa in occasione dell’annuale Convegno delle Stelline o la creazione di alcuni gruppi di lavoro il cui esito professionale rimane del tutto opaco alla comunità bibliotecaria. La comunità locale è se possibile ancor più all’oscuro.
La strategia narrativa in corso di definizione prevede l’apertura di canali di comunicazione con il quartiere Molise-Calvairate e le sue componenti, e con le diverse categorie di stakeholders cittadini: in primis gli operatori della cultura milanese e lombarda, a partire dai bibliotecari la cui rete sarà profondamente influenzata dalla discesa in campo della BEIC; le grandi istituzioni culturali, il mondo dell’editoria e la rete dei librai; gli attori del mondo della formazione e dell’istruzione, in primo luogo le Università e le scuole di ogni ordine e grado, gli insegnanti e gli educatori, nonché l’universo degli studenti milanesi e fuori sede; il terzo settore e alcune comunità professionali come i makers o i gruppi caratterizzati da interessi per la musica, l’audiovideo, l’informatica, che possono svolgere un ruolo attivo anche come produttori di contenuti. I diversi gruppi di stakeholder saranno coinvolti non solo con campagne di comunicazione ma soprattutto attraverso la definizione condivisa di requisiti e prestazioni dei diversi servizi. Particolare importanza rivestirà l’area di cantiere, che sarà attrezzata con un punto di contatto e di incontro con la cittadinanza in cui si potranno ricevere informazioni sempre aggiornata sullo stato dei lavori e sulle attività di advocacy del progetto.
Guardando oltre i confini. Partire dalla tradizione per costruire
il futuro delle biblioteche.
All’oggi tuttavia le cesate di cantiere non raccontano questa storia, così come non racconta alcuna storia un altro importante e positivo cantiere: quello per la realizzazione della nuova rionale del quartiere Lorenteggio, battezzata nel 2018 sui canali social del Comune ed oggi in fase di realizzazione.
Qui vorrei tuttavia concentrarmi su due quesiti solo in apparenza secondari del disegno: la governance e l’assetto il futuro di palazzo Sormani. Acclarato che l’attuale assetto in Fondazione non ha portato con sé rilevanti risorse private, per certo apre alla già citata dispersione delle forme contrattuali ma soprattutto ad un assetto pubblico-privato inedito nel contesto meneghino, che interroga sui costi di gestione di una macchina tanto stupefacente quanto onerosa. Queste risorse chi le metterà a disposizione? Quanto costa attivare, manutenere, far vivere nel tempo lo show della BEIC in un contesto di progressiva e costante contrazione dei trasferimenti verso le amministrazioni locali? Sarà possibile garantire un ampliamento dell’offerta delle rionali in termini di lavori ordinari e straordinari, orari di apertura estesi, assunzioni di personale, rinnovo delle collezioni, a fronte del magnetismo della nuova casa della cultura della città metropolitana?
In questa foresta di domande ce n’è una che sta a cuore a chi ha lavorato, studiato, ricercato nelle mura di Palazzo Sormani. La persistenza di una biblioteca civica centrale al civico 6 di Corso di Porta Vittoria mi pare difficile da immaginare al momento, non fosse altro perché i suoi depositi sono la prima miniera cui attingerà la BEIC. In passato si è parlato informalmente di una sua conversione in spazio espositivo per mostre e installazioni, ma lo spettro della valorizzazione immobiliare è sempre presente. Il posizionamento centrale, specie nella prospettiva di un mai defunto progetto di parziale riapertura del naviglio oggi tombinato, pare deporre a favore di un’ipotesi di privatizzazione. Questo è un disegno da scongiurare, e non facendo leva su nostalgie conservatrici, ma all’insegna di una continuità di vocazione pubblica nel cambiamento funzionale.
Per pretendere maggiore trasparenza, di più, coinvolgimento, è necessario che la comunità bibliotecaria stringa alleanze con la comunità territoriale di prossimità della BEIC, senza dimenticare che la platea del progetto sarà ben più ampia. Eppure proprio qui parte l’innesco adeguato a mutuare la strategia narrativa in una nuova cultura del progetto, in dialogo con i suoi primi stakeholders: lavoratrici e lavoratori, abitanti di storica e recente prossimità, utenza espressa e quella potenziale.