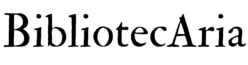Una nuova rissa, con intervento delle guardie in seguito a una conferenza di Arturo Labriola, macchia di sangue la giornata del 23 maggio. Il Paese è in guerra, i socialisti spaccati, la coesione dell’UPM compromessa da tempo. Ad ogni modo se sei arrivat* sin qui senza aver letto le puntate precedenti ti consiglio di ripartire da qui. Se poi leggi questo brano nel giorno esatto della sua uscita (12 maggio ’25) domani sera ci incontriamo a Milano, ospiti di ZAM, per una conversazione sul tema.

Verso la metà di novembre il Corriere della Sera stigmatizza l’indisponibilità degli operai socialisti Bertola e Repossi ad accogliere l’invito dei fratelli bolognesi a promuovere conferenze sui temi della guerra. Mentre il consiglio direttivo approva a maggioranza la divisiva proposta, la componente di classe (forte della sensibilità internazionalista della base dei soci) invita a convocare i soci pallo scopo di scegliere democraticamente l’indirizzo da prendere. Rignano e Varazzani intercettano senza tentennamenti il nuovo trend, Molinari e Serrati tengono la linea: seppur da punti di vista differenti, entrambi sospettano la possibilità di un colpo di mano per spostare con la massoneria gli equilibri interni ad un’UPM sempre più lacerata.
In collaborazione con le biblioteche popolari nasce il bollettino mensile La parola e il libro, e la Federazione trasloca definitivamente a Milano nel 1916. Diverse sedi centrali sono requisite per via delle esigenze di guerra, mentre quelle di Baggio, Sesto, Musocco e in generale nei comuni rurali restano attive. L’UPM è la più solida tra le consorelle, e viene in soccorso delle sedi minori della sua provincia, la cui attività è continuamente minata dalla contrazione dei fondi. Il mese di luglio è segnato dalla crescente pressione politica sull’apoliticità dei corsi: c’è chi come il prof. Bertarelli inneggia alla guerra, chi come i pacifisti è sempre più attenzionato dalle autorità, quando non dalla violenza aperta degli interventisti. Ancora una volta Rignano e Varazzani attaccano la componente operaia, Turati al solito si improvvisa mediatore in appoggio all’equilibrismo apolitico di Fabietti, mentre massimalisti e CDL già intravedono la scissione, e Molinari (che dal suo autoesilio intellettuale ci vede ancora bene) attacca senza mezzi termini gli interessi massonici alle porte dell’UPM. Gli fa eco il giornale di Giacinto Menotti Serrati, che il 19 novembre del ‘17 addita Varazzani di sospette connivenze proprio con la massoneria milanese. L’assemblea convocata il 21 novembre al Teatro del popolo non può che fomentare animi già ribollenti. La guerra prosciuga la partecipazione e distrae con sempre maggior violenza la proposta formativa e gli equilibri interni all’UPM. Il consiglio direttivo firma un esplicito invito alla resistenza sulle pagine de La parola e il libro, che firmano anche i socialisti riformisti Turati, Mondolfo, Ferrari e Ghezzi. Sabatino Lopez concorda, i massimalisti (cacciati, tanto per cambiare, da un’altra conferenza di Margherita Sarfatti) costringono i socialisti riformisti alle dimissioni, accusandoli di ipocrisia. Il 30 novembre, per la prima volta nella storia dell’UPM, l’intero consiglio direttivo è costretto alle dimissioni dopo un attacco a suon di pugni ai pacifisti, in seguito alla clamorosa disfatta di Caporetto. L’assemblea generale è convocata in un clima di estrema tensioni e si protrarrà per ben tre sessioni: da metà dicembre al 1 gennaio 1918.
Quando il 16 gennaio successivo Luigi Molinari scrive La necessità di un divorzio, il PSI ha già chiuso le sue sedi all’UPM. Con l’ennesimo tentativo di rinviare l’esito definitivo, i socialisti elaborano una lista di minoranza per il controllo delle sedi periferiche, in una sorta di spartizione delle aree d’influenza (e dell’utenza) in un nuovo consiglio direttivo da “separati in casa”. Si lavora incessantemente al nuovo Congresso delle UP e delle scuole libere di cultura, in cantiere per l’anno successivo…ma chi ha veramente il polso degli umori della massa degli iscritti? Turati gioca ancora in bilico, non ha intenzione di lasciare l’UPM ma non vorrebbe nemmeno che un’Università proletaria non presidiata possa togliergli ulteriore terreno sotto i piedi. Ad ogni modo a causa delle minacce che riceve personalmente il Congresso della coltura popolare viene rinviato.
La FIUP nell’ottobre del 1922 conta ufficialmente 58 UP aderenti, al congresso del settembre ‘23 partecipano una quarantina di queste, specialmente quelle aventi sede al centro-nord. In questa fase La parola e il libro è divenuto il mensile ufficiale della Federazione. Il fascio milanese s’interessa maggiormente all’UP, retta da non più da Giulio Pisa ma da Sabatino Lopez, che offre un volto di sé afascista, eppure sempre più interno a una retorica nazionalista, probabilmente nel tentativo di tenere in vita un’istituzione dal futuro sempre più incerto. L’inaugurazione della nuova sede presso il Liceo Manzoni era stata posticipata di una settimana per via della visita dei sovrani in città, in agenda il 13 aprile 1924, cui l’UP partecipa in delegazione alla sfilata. Gli iscritti sono ancora 4000, ma i mutamenti si fanno sentire: l’anno successivo il vessillo viene snaturato. I tempi di Gnocchi-Viani e Osimo sono sempre più lontani, Varazzani e Rignano (che si ravvede solo quando è troppo tardi) sono sempre più gli unici elementi di continuità con le stagioni precedenti.
Nonostante gli sforzi profusi per adeguarsi ai tempi che corrono nel 1926 il regime chiude i conti anche con Lopez: il 3 dicembre i fascisti si iscrivono in massa e in camicia nera costringono il consiglio alle dimissioni. Viene nominato reggente di quel che resta dell’UPM un suo uomo di fiducia, il generale Ferdinando Negrini, che traghetta definitivamente l’esperienza verso la fascistizzazione con lo statuto del gennaio ‘27. Il regolamento del tempo prevedeva di procrastinare il diritto di voto solo a partire dal sesto mese di adesione. A fronte dell’opposizione di un socio Negrini risponde con queste parole: Dovrei fare un’inchiesta, dovrei fare un’infinità di cose che, giudicate tra un’ora, sembrerebbero inutili, perché credo che questa sia l’ultima assemblea dell’UPM. Non passa una settimana che il podestà sblocca i fondi pubblici un tempo congelati, i programmi didattici ne escono stravolti e il bollettino viene deturpato in prima con il fascio littorio. La porte dell’UPM vengono spalancate a quattromila avanguardisti mentre il consiglio entrante sarà decretato dal podestà e dal fascio di Milano. Ultima tappa dell’occupazione dell’UPM sarà la sua soppressione e assorbimento nella cornice dell’Istituto nazionale di cultura fascista dieci anni più tardi.
All’indomani del 25 aprile 1945, liquidato anche questo istituto, l’UPM risorge nella sede del Partito d’Azione di Corso Monforte 30, quindi in piazza Sant’Alessandro e infine nella sede di via Terraggio, a partire dal 1990, col contributo di un’altra generazione di Lopez, il figlio Guido. Paradossalmente cronache così dettagliate di un’appassionante storia lunga un secolo si fanno davvero rarefatte per quanto riguarda il periodo che vede la crisi di questo organismo in una Milano profondamente mutata, e l’avvento di internet appena alle porte.
Attualmente ogni marchio legato a questa interessantissima, controversa, strattonata esperienza di ateneo popolare è stato registrato da una chiacchierata università online, che rivendica non solo un legame storico con l’UPM, ma anche una primogenitura dell’istitituto da parte dello scultore e massone Ettore Ferrari, che nessun’altra fonte (a me nota, sia chiaro) riporta. Purtroppo questa versione, tesa anche a sopravvalutare il contributo di d’Annunzio e parallelamente cancellare la complessità della storia che abbiamo riassunto per sommi capi, è stata riportata acriticamente su Wikipedia e di lì su diverse note testate troppo distratte per accorgersi della “confusione” o decisamente attente a mescolare contenuti sponsorizzati e contenuti giornalistici sull’altare degli introiti pubblicitari. L’esito scontato ci parla di un’operazione di rimozione e mistificazione di una vicenda tanto importante per la storia della città e sei suoi istituti culturali, su cui non abbiamo comunque detto ancora tutto.
E l’Università Proletaria? Questo è il tema del quinto e conclusivo brano del ciclo, che sarà disponibile il prossimo 26 maggio.
L’mmagine di copertina, rilasciata in pubblico dominio, ritrae via Verziere a Milano un secolo fa.